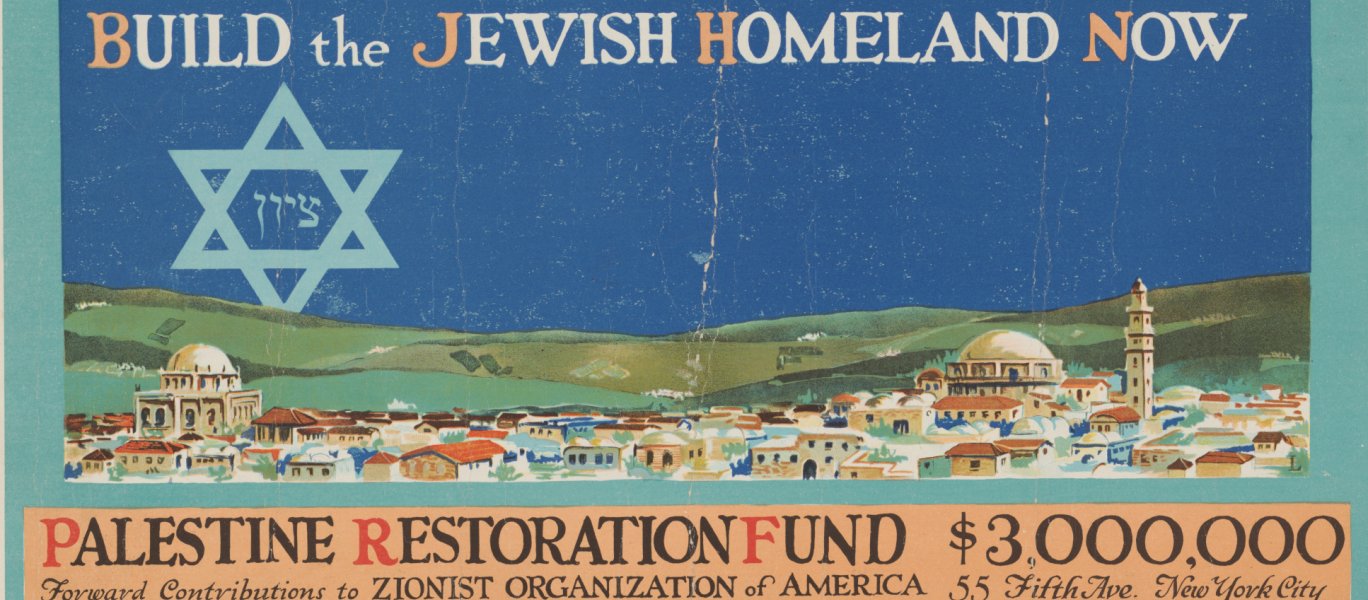
Per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo.
C’è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare.
Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire.
Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare
— Qoèlet 3,1-4
Gaza per Israele è l’assedio permanente, il trauma del 7 ottobre, la convinzione di non poter abbassare mai la guardia. Gaza per Hamas è gloria, resistenza e eroico martirio, il teatrino televisivo della vittoria nella sconfitta. Gaza per l’ONU la certificazione della propria impotenza e inutilità: conferenze stampa drammatiche, e poi camion di aiuti che non entrano, impantanati tra corruzione e opportunità politiche.
Per noi Gaza è un servizio giornalistico visto in streaming, un commento rilanciato sul social preferito…
Su Gaza c’è però un silenzio imbarazzante: gli ostaggi. Le centinaia di persone rapite il 7 ottobre 2023, strappate alle loro case, usate come moneta di scambio. Ne rilasciano qualcuno, col contagocce, con precisione mediatica rara. E noi, il pubblico, consumiamo anche questo dolore a puntate.
Per noi Gaza è un test: quanto possiamo sopportare, da spettatori, prima di cambiare canale?
Poi i morti. Che non sono solo i morti quotidiani di Gaza, quelli che conosciamo dalle immagini strazianti dei bombardamenti che ci vengono propinate ogni giorno, ci sono anche i morti del 7 ottobre, israeliani. Quelli che hanno fatto da detonatore a tutto questo. I civili bruciati vivi, le famiglie sterminate, donne, ragazze violentate, bambini uccisi a mani nude, è una ferita che Israele non dimenticherà mai.
Chi grida contro Israele non vuole ricordare che tutto è iniziato da un massacro.
Chi difende Israele non vuole ricordare che oggi sta massacrando a sua volta civili inermi.
Gaza è diventata il luogo dove bisogna scegliere da che parte stare, è ormai un obbligo sociale. O con Israele, “democrazia assediata” che risponde al terrorismo e al fondamentalismo. O con i palestinesi, “popolo martire” ridotto alla fame e alle macerie. Il risultato è una somma di incomprensioni. Un conflitto visto a metà: o il dolore palestinese, o quello israeliano, ma mai entrambi insieme.
Provo, anche a costo di parer democristiano, a dire l’ovvio: nessuno ha tutte le ragioni e nessuno ha tutti i torti. Hamas ha aperto questo ciclo di violenza con un massacro di civili il 7 ottobre 2023, rapendo ostaggi come fossero un bottino medievale. È terrorismo puro, non resistenza.
Israele risponde con una guerra che colpisce un’intera popolazione: bombardamenti a tappeto, fame indotta, ospedali ridotti a cimiteri. È punizione collettiva, non difesa.
Entrambe le verità sono scomode. Perché chi sostiene i palestinesi non vuole ricordare gli ostaggi ancora prigionieri. E chi difende Israele non vuole ricordare i morti a Gaza. Il dolore israeliano e quello palestinese.
Guardarli entrambi non è equidistanza: è l’unico modo per non vedere il mondo orbati, incapaci di capirlo.
Quando le opinioni smettono di essere opinabili si trasformano in ideologie esistenziali. Non si dice più: “penso questo”. Si dice: “io sono questo”. E chi non la pensa come me non è solo in errore, è un nemico. Devi scegliere la curva: gradinata sud o gradinata nord, con sciarpa al collo e bandiera inastata. Ogni sfumatura di pensiero viene spacciata per vigliaccheria, ogni tentativo di tenere insieme verità provenienti da fonti opposte per “cerchiobottismo”.
Forse succede che quando un sistema di valori non dà più risposte adeguate allora si sente il bisogno di trasformare qualunque opinione in verità totalizzante. Le idee diventano ideologia, la politica non è più negoziazione, ma guerra di religione in cui la verità non conta: conta solo resistere al nemico, anche a costo di rinunciare a guardare in faccia la realtà. Forse è questa la vera fine di un impero, di una civiltà: non quando perde territori o ricchezza, ma quando perde la capacità di discutere senza trasformare ogni disaccordo in una guerra.
E pensare che l’Occidente è nato litigando. Papi contro Imperatori, università contro monarchie, città contro feudi: uno scontro continuo dove però nessuno riusciva schiacciare del tutto l’altro. E da quel rumore di fondo sono nati pluralismo, scienza, diritti individuali. Oggi litighiamo ancora, ma non per aprire spazi, anche conflittuali eppure fertili di conseguenze. Oggi restano solo tifoserie chiuse in bolle mediatiche inaccessibili alla critica.
- Libri
- Alessandra Tarquini, La sinistra italiana e gli ebrei. Socialismo, sionismo e antisemitismo 1892-1992, Il Mulino, 2019
- Paola Caridi, Hamas. Dalla resistenza al regime, Feltrinelli, 2023
- David G. Dalin, John F. Rothmann, La mezzaluna e la svastica. I segreti dell’alleanza fra il nazismo e l’Islām radicale, Lindau, 2015
- Claudio Vercelli, Storia del conflitto israelo-palestinese, Laterza, 2010

