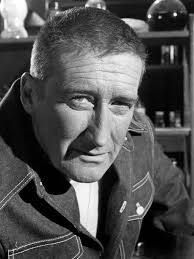«Quando ritornai nella valle del mio essere, portai questo canto e le penne di nove uccelli dalla regione selvaggia, dalla strada del coyote; e dai sette anni in cui vissi nella Città dell’Uomo portai la mia femminilità, la bambina Ekwerkwe, e la mia amica Ombra»
— Ursula K. Le Guin, Sempre la Valle (1985)
Il viaggio iniziatico al tempo del tutto compreso
Il passo di Le Guin evoca il viaggio come processo di trasformazione: si parte frammentati e si ritorna con un canto nuovo, una nuova personalità — segni di un’identità ricomposta. Un itinerario interiore, irrepetibile e non delegabile. Oggi l’avventura è in formato tutto compreso: tappe predefinite, paesaggi garantiti, pericoli sterilizzati. Il selvaggio diventa user‑friendly e l’esperienza iniziatica si riduce a un servizio con diritto di rimborso. È questa frizione che attraversa le righe che seguono.
Nel 2020 pubblicavo un post intitolato Magic Bus. Parlavo di quell’autobus sgangherato — il “Bus 142” di Into the Wild — diventato calamita per pellegrini in cerca di un pezzo di avventura prefabbricata. Già allora il paradosso mi colpiva: centinaia di persone volavano fino in Alaska per «fuggire da tutto», salvo ritrovarsi in coda sullo stesso sentiero, con lo smartphone puntato sulla lamiera verde.
La storia si è chiusa nel giugno 2020, quando la Guardia Nazionale dell’Alaska ha sollevato il bus con un elicottero e l’ha depositato in un museo: troppi interventi di soccorso, due morti e una ventina di evacuazioni in dieci anni. (repubblica.it)
Ma il rito collettivo non è scomparso. Si è semplicemente spostato.
Oggi la parola wild è ovunque: dalle etichette dei deodoranti alle campagne Instagram dei grandi comprensori sciistici. Come nota Luca Fontana in un estratto del suo saggio Tornare a esplorare, il termine «selvaggio» è passato dal far paura a diventare uno slogan pubblicitario, appiccicato a foto di laghi color Photoshop e bagni nordici in botte. (linkiesta.it)
«La montagna è diventata un passatempo, svuotata del fascino dell’esplorazione» — L. Fontana
Il processo è lo stesso che ha investito il Bus 142: il simbolo di un tragico percorso intimo e personale viene impacchettato, duplicato, rivenduto in massa. Il tempo lento dell’avventura cede il passo alla fruizione rapida e collettiva.
Per secoli le Alpi sono state officina di sopravvivenza: fieno, pascoli, cave, legna. Oggi le funivie depositano migliaia di sciatori dove un tempo salivano solo pastori. Nei press‑kit si parla di «paradiso incontaminato», ma i tracciati delle piste somigliano a cicatrici e i cannoni sparaneve lavorano anche con +5°C in dicembre.
Questi grandi comprensori sono non‑luoghi1, come li definiva Augé: spazi di transito senza identità, relazioni o memoria, progettati per il consumo rapido e l’oblio. Il turista passa, scia, compra, riparte; la relazione con il territorio si riduce a un ticket RFID nel taschino.
Il paesaggio che Fontana definisce «uno dei più costruiti che esistano» non è un’eccezione: l’intero arco alpino è stato antropizzato fino al midollo. Eppure il marketing outdoor continua a venderlo come Eden vergine.
Il Tour du Mont Blanc è un caso‑scuola. Negli anni ’80, racconta Fontana, i suoi genitori ricordano sentieri silenziosi; nel 2023 il circuito ha registrato circa 50 000 trekkers più un’orda di day‑hikers. Gli hashtag #TMB e #Alps collassano qualunque sfumatura in una corsa al “belvedere certificato”: stessa foto, stesso filtro, stessa didascalia motivazionale.
Quando l’obiettivo diventa “spuntare la lista” – il bus, il bivacco rosso, l’altalena panoramica – l’esperienza si appiattisce. E, paradossalmente, aumenta il rischio di incidenti: ci si avventura senza conoscenza del luogo, affidandosi più a Google Maps che alla lettura del cielo, del tempo atmosferico, dell’ambiente.
Recuperare la fatica, il tempo, l’imprevisto
Nel mio vecchio post scrivevo che «abbiamo il dovere di cercare il nostro “luogo selvaggio”». Oggi aggiungo: dobbiamo farlo senza pretendere che sia pronto all’uso. E tuttavia possiamo soltanto ridurre l’impatto di questa massificazione, non azzerarlo. Una soluzione definitiva — che non passi per una drastica riduzione demografica — non esiste. E allora:
- Camminare invece di “consumare chilometri”. Fontana racconta come la camminata lenta lo abbia «ripulito» da idee altrui. Ci risparmia la fila alla cabinovia e ci restituisce la scala reale delle distanze.
- Accettare la presenza del pericolo, non eliminarlo. Imparare a usare la cartina, imparare a riconoscere un cumulonembo in crescita, a convivere con la fauna (orsi compresi) senza demonizzarla. Insomma, impariamo a riconoscere i nostri limiti rispetto all’ambiente (se non sei allenato e preparato tecnicamente, sul ghiacciaio non ci vai…).
- Destagionalizzare. Esplorare in bassa stagione riduce l’impatto sul territorio e restituisce silenzio (sì, esiste ancora).
- Partecipare alla manutenzione dei sentieri o a un progetto di volontariato ambientale. Dal ripristino delle mulattiere alla raccolta dati sulla biodiversità.
- Raccontare con onestà. Se pubblichiamo foto, aggiungiamo il contesto: quante ore di salita, quali difficoltà, quali alternative sostenibili al parcheggio in quota.
Insomma…
Insomma, il Bus 142 in un museo, le Dolomiti in un carosello di reels: l’esito è lo stesso, lontananza addomesticata. Ma la natura non è un servizio a buffet. È un incontro, spesso scomodo: pioggia e fango, vento contrario, deviazioni non segnate.
Riconsegnare alla montagna — e a noi stessi — questa quota di incertezza significa de‑turistificare lo sguardo: tornare a esplorare anziché consumare.
La prossima volta che sentirete il richiamo di un “luogo selvaggio” chiedetevi: sto seguendo un copione altrui o sto scrivendo il mio?
Portate con voi una borraccia, una bussola e una cartina, non un hashtag da esibire. E, se potete, lasciate la meta un po’ migliore — o almeno non peggiore — di come l’avete trovata.
- Libri
- — Luca Fontana, Tornare a esplorare (Rizzoli, 2025)
- — Lawrence Osborne, Il turista nudo (Adelphi 2006)
- — Marc Augé, Non luoghi. Introduzione a una antropologia della surmodernità (Eleuthera, 1996)
-
Marc Augé definisce i nonluoghi in contrapposizione ai luoghi antropologici, quindi tutti quegli spazi che hanno la prerogativa di non essere identitari, relazionali e storici. Fanno parte dei nonluoghi sia le strutture necessarie per la circolazione accelerata delle persone e dei beni (autostrade, svincoli e aeroporti), sia i mezzi di trasporto, i grandi centri commerciali, gli outlet, i campi profughi, le sale d’aspetto, gli ascensori eccetera. Spazi in cui milioni di individualità si incrociano senza entrare in relazione, sospinti o dal desiderio frenetico di consumare o di accelerare le operazioni quotidiane o come porta di accesso a un cambiamento (reale o simbolico). Wikipedia ↩